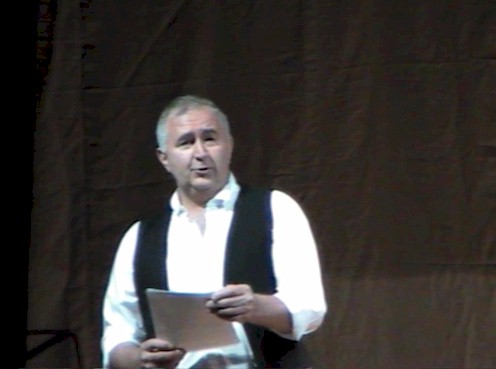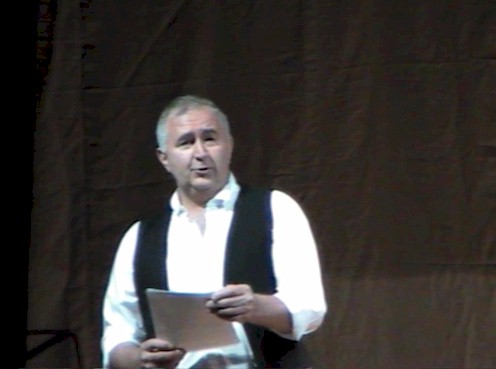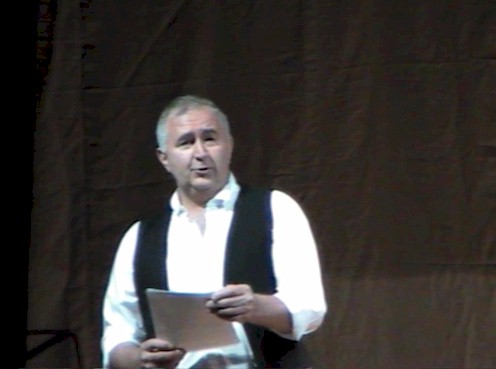 |
Vecchie storie del mio paese e della mia città che rasentano oramai la leggenda metropolitana, dove strambi episodi di vita nei campi si intrecciano con una civiltà del vivere che ormai non esiste più, e che iniziava a quel tempo la marcia verso la modernizzazione.
|
Allora ci si spostava quasi sempre a piedi, tagliando per i campi, o -per distanze maggiori- in bicicletta.
Ed è qui che troviamo i tabiunàr Mamante e Delmo Fachėn,
il ladro Fasān, la Giusi che ballava
al suono dei clacson, Salėn che saltava
nel mezzo di una rissa per scazzottarsi al posto di uno sconosciuto
poco combattivo.
|
 |
|
Personaggi metā veri
e metā da leggenda di paese, un paese immerso nelle nebbie autunnali
e nella spietata afa della campagna ferrarese, fra il puzzo del letame
e il profumo del pane cotto nei forni a legna delle casone.
|
|
|
Tanti, tanti anni fa,
con la guerra in corso o appena finita, con gli spernacchianti Mosquito
che portavano i braccianti al lavoro negli anni '50, Gildo
e Cunsòrzzi a fare la prima esperienza
di sesso, Carlaza che sparava alle biciclette
nel buio pių pesto, la famiglia Suriān proprietaria
di una paletta giustiziera.
|
 |
Spettacolo di racconti
semiseri e semiveri, dove il dialetto si intreccia con l'italiano
con la scarsa eleganza di una pronuncia sgiaronata, come si
dice Qui da noi :che in dialetto ferrarese si dice Chi 'd zzā da
nu, inventandone quasi di sana pianta l'ortografia.
Ma preferisco
scriverlo Kidzadanù.
Scritto così evoca idiomi africani e balcanici, sa di caldo, di vita scomoda, di legami antichi, di relazioni di convivenza che non sono state scritte da nessuno ma che tutti conoscono e si portano dentro ovunque vadano, di qualcosa che non conosciamo più e che ci è diventato estraneo, pur soffrendone l'assenza.
E forse è proprio l'estraneità da quelle che sono invece piccole storie di un nostro quotidiano appena trascorso, l'ingrediente che rende queste narrazioni comiche da un lato e un po' malinconiche dall'altro.
|
|